Ciclidi del Malawi: Il genere Labeotropheus
Articolo scritto da Luca Balzani
Famiglia: Cichlidae
Sottofamiglia: Pseudocrenilabrinae
Genere: Labeotropheus
Il nome Labeotropheus deriva dal latino ed è traducibile come tropheus
dalle grandi labbra, labeo fa riferimento alla analoga famiglia dei
ciprinidi.
Il genere Labeotropheus è suddiviso in due grandi specie quella del
Labeotropheus fuelleborni in onore del Prof. Dr. F. Fuelleborn e quella
del Labeotropheus trewavasae in onore di Dr E.Trewavas.
Il Labeotropheus fuelleborni ha una
chiara preferenza per un habitat roccioso caratterizzato da un
substrato privo di sedimenti e con un manto algale che copre il duro
substrato (copertura biologica) contenente molte fibre di alghe
fermamente attaccate. Si può anche trovare in mucchietti di roccie in
mezzo alle spiagge sabbiose, specialmente nei punti esposti alle onde.
Il L.fuelleborni ha subito un processo di adattamento per vivere nei
tratti superiori dell’habitat roccioso, sviluppando due caratteristiche
particolari. Una di queste caratteristiche, che condivide con il
congenere Labeotropheus trewavasae, è un ampia bocca ventrale abbinata
ad un notevole e carnoso “naso”.
Quando si tiene il pesce sottosopra, si vede che la bocca è una linea
dritta che attraversa la larghezza totale della testa. La sua posizione
ventrale permette al Labeotropheus di nutrirsi in una posizione quasi
parallela alle rocce, con il corpo che forma un angolo di circa 30°
rispetto al substrato. Il Labeotropheus rimane dunque in stretto
contatto con il substrato mentre tagliuzza le alghe.
Sia il naso che il mento sono callosi, probabilmente a causa del
continuo contatto con il ruvido substrato durante la nutrizione. Il
naso, fruttato come una leva, permette di fare leva nel mentre la bocca
afferra l'alga filamentosa. Questo effetto combinato permette così di
strappare le alghe afferrate con la bocca. Questa tecnica di nutrizione
non solo gli fa risparmiare energia ma permette anche al Labeotropheus
di rimanere in stretto contatto con le rocce, riducendo in tal modo il
rischio di essere spazzato via delle acque turbolenti. Inoltre gli
fornisce una maggiore quantità di alghe (attaccate più saldamente) che
possono essere raccolte usando le tre o più file di denti tricuspidi
delle mascelle più esterne; questo metodo di nutrizione è così
effiecente che le alghe vengono completamente rimosse, lasciando dei
visibili graffi nella copertura biologica. La grande taglia comunemente
osservata dei L.fuelleborni (una lunghezza totale massima di circa 18
cm) può essere un’indicazione degli effetti benefici del "naso".
In posti dove la turbolenza delle onde è massima, le alghe sono
fortemente ancorante al substrato e raccoglierle richiede non solo delle
mascelle forti, ma anche un maggiore sviluppo del “naso”. I
Labeotropheus che vivono in tali aree hanno un naso più prominente
rispetto agli individui che si nutrono dalle copertura biologica. Più
fortemente e più frequentemente il naso viene premuto contro il
substrato e più sembra crescere in larghezza. E più cresce in larghezza
più l’angolo di nutrizione che il pesce può tenere con il substrato è
piccolo. Simili stimolazioni di crescita possono essere notate nei
ciclidi con labbra più carnose, così come i Placidochromis milomo e i
Chilotilapia euchilus. La seconda caratteristica che assicura ai
L.fuelleborni una posizione (fisica) stabile in questo habitat è il suo
corpo letteralmente compresso. Insieme ad un’estesa pinna dorsale, che
si comporta come una vela, rendendolo più stabile e meno in balia della
corrente.
I maschi di L.fuelleborni difendono il loro territorio con gran vigore,
specialmente contro i maschi conspecifici. Le femmine e i maschi
non-territoriali si congregano in gruppi e si nutrono nelle parti più
alte dell’habitat. Il L.fuelleborni non frequenta zone più giù di 35
metri di profondità. Ciò significa che la popolazione degli habitat
rocciosi separati dalle acque più profonde di questa, sono praticamente
isolate. Questo può aver portato a molte varianti di colore di questa
specie.
La colorazione della femmina non varia molto nell’intera gamma della
specie. Per via della particolare forma, la colorazione può essere di
minore importanza nel riconoscimento del compagno. Ciò può anche
spiegare i morfi arancioni (O) e quelli arancioni a macchie (OB)
presenti sia nei maschi sia nelle femmine. Se una femmina può
riconoscere un con-specifico solo dalla sua silhouette, la riproduzione
potrebbe in teoria avvenire senza la presenza della colorazione nel
maschio.
Altre importanti funzioni dei colori brillanti sono l'espressione del
dominio su un territorio, della disponibilità del luogo di deposizione,
il segno dell’essere sano e prestante del maschio.
Certamente la riproduzione con dei maschi non colorati è lontana dalla
situazione normale, ma è comunque presente un piccolo numero di maschi
OB (“gatti marmellata”/”marmalade cats”).
In qualche luogo più del 50% delle femmine può appartenere al morfo
ob/o; solitamente questo avviene in posti dove il L.trewavasae non è
presente; ad esempio nelle isole Mbenji e Chinyamwezi. A mbenji il raro
morfo O del maschio è visto solo occasionalmente. In tali posti il
L.fuelleborni penetra anche nelle regioni più profonde, di solito
abitate dal T.trewavasae. La classe a macchie arancioni della femmina
può essere un esempio di colorazione di mimetizzazione, specialmente tra
le rocce nelle aree più profonde. Si vede più spesso nel T.trewavasae
che vive una vita più nascosta in tali aree.
Per quanto riguarda la riproduzione il Labeotropheus è inusuale tra gli
mbuna. Le uova sono fertilizzate fuori dalla bocca della femmina
(Trewavas & Konings 1992). Dopo che la femmina ha depositato qualche
uovo, il maschio, che la segue, le fertilizza nel substrato. La
femmina, nel frattempo, disegna un grande cerchio e poi raccoglie le
uova nel suo passaggio di deposizione, immediatamente prima di
depositare il suo prossimo gruppo. La prole, che viene lasciata per la
prima volta dopo 3 settimane, trova rifugio dentro la bocca della
femmina per almeno un’altra settimana (Schonen, 1979). Gli egg-spots
(ocelli) nella pinna anale del maschio sono proporzionalmente i più
piccoli (in confronto alla taglia adulta del pesce) tra quelli osservati
negli mbuna, mentre le uova sono tra le più grandi.
Il Labeotropheus trewavasae è un mbuna piuttosto comune in molte zone lungo le rive rocciose del lago.
Assomiglia alla sua specie congenere, L. fuelleborni, in quasi tutti
gli aspetti anatomici, ma ha un corpo più affusolato e preferisce acque
più profonde , infatti la maggior parte di loro è stata vista tra i 5 e i
10 metri di profondità. Il suo corpo allungato gli permette di
penetrare in piccoli buchi e crepe tra le rocce. È specializzato nel
raschiare e raccogliere alghe dalla superficie ricca di sedimenti e si
nutre prevalentemente dalle facce verticali e dalle parte inferiore
delle rocce.
La sua tecnica di nutrizione e l’ accoppiamento sono simili a quelle descritte sopra per L. fuelleborni.
In alcuni reef è presente solamente il L. trewavasae ed è interessante
osservare che in questi casi, lo stesso, presenta un corpo più massiccio
rispetto agli esemplari delle coste rocciose adiacenti dove vivono
entrambe le specie del genere. La profondità del corpo può variare in
maniera considerevole in questa specie. A Chirwa Island vicino a
Chilumba ad esempio, grandi esemplari arancioni di L. trewavasae
assomigliano a L. fuelleborni sia nella taglia che nella forma.
Il L. trewavasae ha una distribuzione molto ampia. Si trova sulla
maggior parte delle coste rocciose eccetto a Mbenji Island. E’ presente
in alcuni luoghi dove il L. fuelleborni è assente, come ad esempio a
Jalo Reef, Taiwanee e Linganjala, rispettivamente a nord e ad ovest di
Chizumulu.
Sono rari i casi dove i maschi sia di L. fuelleborni che di L.
trewavasae sono interamente blu, per esempio, a Mara Rocks, Chilucha e
Minos Reef in Mozambico. Nella maggior parte degli altri reef è
presente una sola delle specie o esse sono di colore diverso.
Ci sono tre pattern di colore principali conosciuti per entrambi le
specie e ognuno ha un singolo pattern specifico per ogni specie.
La colorazione più comune nei L. fuelleborni è completamente blu con
delle barre distintive nei maschi territoriali. Il L. trewavasae ha
anch’esso delle specie completamente blu, ma la variante a Nkhata Bay,
per esempio, è blu cobalto e può dunque essere distinta dal L.
fuelleborni royal blu nella stessa location. A minos Reef (Mozambico) la
situazione è inversa: qui è il L. fuelleborni ad essere blu cobalto.
Il secondo pattern di colore visto in entrambe le specie è
caratterizzata da corpo azzurro con una pinna dorsale rossa o arancione
(‘red-tops’).
La terza tipologia comprende una colorazione gialla, arancione o marrone
ruggine sui fianchi, sulla pancia e/o sulla parte dorsale del corpo.
Nella stessa location entrambe le specie potrebbero avere l’arancione
sul corpo. Nel L. trewavasae ciò è limitato alla metà superiore del
fianco mentre nel L. fuelleborni è invece presente sulla metà inferiore.
A Higga Reef, Ngkuyo Island e presso la costa rocciosa a sud di Mbamba
Bay, un unico pattern di colore si verifica nel L. trewavasae che
presenta un corpo blu e un’ampia banda nera submarginale sulle pinne
anali e dorsali. Tale caratteristica non solo è unica del L. trewavasae
ma è anche limitata a queste poche popolazioni vicino Mbamba Bay in
Tanzania. Anche alcuni maschi di L. fuelleborni a Chinyankwazi Island
nel braccio sud-orientale del lago, presentano la stessa caratteristica
ma hanno una banda nera sulla dorsale e nessuna sulla pinna anale.
I tre pattern di colore principali formano parte della normale
variazione genetica delle due specie. Il colore base sembra essere il
blu in quanto questa è l’unica forma vista in quasi tutte le regioni
dove solo una delle due specie è presente.
Le altre colorazioni potrebbero essersi sviluppate per aiutatare a
differenziare tra loro le due specie quando queste si sono trovate in
contatto .
La variazione di pattern di colore è più vistosa nelle popolazioni adiacenti di L. trewavasae rispetto al L. fuelleborni.
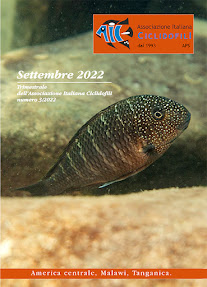
Commenti
Posta un commento