Ciclidi del Malawi: Il genere Copadichromis
Articolo scritto da Ivan Salvadori
Specie tipo:Copadichromis quadrimaculatus (Regan, 1922)
Trewavasae ed Eccles nel 1989, in Malawian cichlid fishes. The classification of some Haplochromine genera, hanno posto le basi dell’attuale classificazione dei ciclidi del Malawi che è largamente basata sui vari tipi di pigmentazione di base, detta anche pattern. Questi sono senz’altro tra i caratteri più importanti per indicare i rapporti di parentela tra i vari generi.
Nello stesso lavoro, descrivevano quindi il nuovo genere Copadichromis (specie tipo Haplochromis quadrimaculatus) il cui nome deriva dal greco kopadi che significa "branco", ovviamente di pesci, e dal suffisso chromis che sta ad indicare pesce. Il nome deriva quindi dall'osservazione di questo genere che normalmente viene visto in branchi. Trewavasae ed Eccles, nella suddetta opera, li descrivevano come ciclidi che si nutrono di plankton di taglia medio piccola. Gli ambienti frequentati dalle specie apparteneti al genere sono quelli rocciosi, di transizione e di acqua aperta. Sono caratterizzati dall’avere una bocca piccola, con deboli mandibole, con piccoli denti ricurvi monocuspidi che nelle femmine e nei piccoli possono essere bicuspidi, sono caratterizzati da un pedicello premascellare allungato, che può essere esteroflesso in avanti formando una bocca protrattile. Piccoli e fitti denti sulla mascella faringeale inferiore, ed un elevato numero, dalle 12 alle 28, di branchiospine sul primo ceratobranchiale. Il genere inizialmente conteneva 17 specie includendo oltre alle sette specie originariamente descritte da Trewavas nel 1935: H. pleurostigma, H.eucinostomus, H.inornatus, H.cyaneus, H.prostoma, H.chrysonotus, H.quadrimaculatus anche altre 10 specie descritte da Iles nel 1960: H.flavimanus, H.mloto, H.virginalis, H.boadzulu, H trimaculatus, H.nkatae, H.jacksoni, H.borleyi, H.pleurostigmoides, H.likomae.
Successivamente Konings tra il 1990 ed il 1999 descriveva C.azureus, C.mbenjii, C.verdujni, C.trewavasae, C.ilesi, e C.geertsi e Stauffer, insieme ad altri, nel 1993 ed insieme a Sato nel 2002, descrivevano: C.conophorus, C.cyclicos, C.thinos e C.atripinnis.
Il lavoro fatto da Stauffer e altri studiosi nel 1993 fu molto importante perchè dimostrarono come la forma e la costruzione del nido siano una manifestazione dei tratti comportamentali ed usarono la forma del nido per delimitare raggruppamenti tassonomici tra le varie specie del Lago Malawi. Basandosi su differenze comportamentali e morfologiche, divisero il genere Copadichromis, in cinque gruppi distinti.
Successivamente, nel 2006, Stauffer e Konings pubblicarono uno studio in cui venivano descritte sei nuove specie: C.melas (ex Copadichromis sp. “midnight mloto”), C.chizumuluensis (ex Copadichormis sp.”chizumulu blu”) , C.diplostigma (ex Copadichrmis sp.”likoma blu”), C.insularis (una parte di C.azureus), C.cyanocephalus (ex Copadichromis sp.”verdujni bluface”) e C.parvus (ex Copadichromis sp.”verdujni dwarf”) e spostarono due dei gruppi descritti dallo stesso Stauffer nel 1993.
Il primo gruppo, caratterizzato da una banda laterale mediana ed un corto pedicello caudale a cui appartenevano C.prostoma e C.boadzulu vennero inclusi nel genere Nyassachromis.
Il secondo gruppo, che si differenziava in modo significativo sia da un punto di vista morfologico che “comportamentale”, diede vita al genere Mchenga. Infatti da un punto di vista morfologico ci sono differenze sia nel pattern melaninico di base, sia nel numero relativamente basso di branchispine sul primo ceratobranchiale e sia nei denti bicuspidi della fila esterna della mascella orale nei maschi, che, nel genere Copadichromis, presentano invece almeno alcuni denti monocuspidi. Dal punto di vista “comportamentale” vi sono grosse differenze di habitat e di costruzione dei nidi che non includono, in queste specie, alcuna roccia o pietra e che vengono quasi sempre, costruiti sulla sabbia.
Dopo questo nuova revisione le specie che rimangono nel genere Copadichromis sono identificate come appartenenti a tre gruppi.
Il gruppo C.quadrimaculatus, il gruppo C.mbenjii ed il gruppo C.virginalis.
Come tutte le specie animali, anche i maschi dei Copadichromis si devono scontrare con due obiettivi contrastanti che riguardano la loro strategia riproduttiva: farsi notare dalle femmine dimostrando il loro vigore e la loro disponibilità alla riproduzione e trovare un posto sicuro e protetto dove riprodursi, per questo motivo l'ambiente in cui si riproducono influenza notevolmente la loro strategia riproduttiva.
Per esempio le specie di Copadichromis che si riproducono in zone rocciose, usano, come zona di riproduzione, quelle meno desiderabili dai potenziali predatori e ladri di uova presenti in questo habitat. Tendono, infatti, ad usare la superficie esposta dei grandi massi che, non offrendo protezione agli mbuna che sono i principali abitanti di questo ambiente, vengono da questi ultimi trascurate.
Quindi, le specie di Copadichromis che si riproducono in habitat roccioso lo fanno lungo una parete verticale di un masso o sotto una sporgenza sovrastante dove l’ombra permette una protezione maggiore dai predatori. Ovviamente, la riproduzione sui massi in habitat roccioso comporta per i maschi territoriali, un grande sforzo energetico per mantenere libero il nido da potenziali predatori e rivali e in considerazione di questo si pensa che i Copadichromis che usano come luogo di riproduzione i grandi massi in habitat puramente roccioso presentano un tratto comportamentale più ancestrale, ossia meno evoluto, tra i Copadichromis, visto che è sicuramente la strategia più dispendiosa.
Tra le strategie per affrontare in modo diverso l'ostile ambiente roccioso abbiamo specie che hanno imparato a riprodursi soltanto durante un particolare periodo dell’anno nel quale quasi tutti i membri adulti di una popolazione si riuniscono in branco. Quest’ultimo comportamento che è stato studiato solo in C.quadrimaculatus (Fryer & Iles, 1972), è in realtà presente anche in altre specie come C.ilesi e C.virginalis, entrambi appartenenti al gruppo C.virginalis. E' facile intuire che la presenza contemporanea nella zona rocciosa, di un enorme numero di utaka che si riproducono, diminuisce la probabilità di predazione delle uova.
Ma il riunirsi in grupppo non è l'unica strategia che le specie di Copadichromis usano per proteggere le proprie riproduzioni. Infatti abbiamo specie che hanno deciso di abbandonare in parte l'habitat roccioso per trasferirsi nella zona di transizione e costruire nidi nella sabbia a ridosso di una roccia o parete rocciosa. Questo modo di riprodursi presenta il vantaggio che il nido è più riparato, cosa che non può essere offerta dall’ambiente roccioso e specie che si riproducono in acqua libera.
Questi comportamenti dimostra un carattere comportamentale dedotto, perchè migliorativo rispetto a quello ancestrale.
Specie descritte appartenenti al gruppo C.quadrimaculatus:
· Copadichromis borleyi
· Copadichromis chrysonotus
· Copadichromis cyaneus
· Copadichromis geertsi
· Copadichromis jacksoni
· Copadichromis nkatae
· Copadichromis pleurostigmoides
· Copadichromis quadrimaculatus
· Copadichromis trimaculatus
Specie descritte appartenenti al gruppo C.mbenjii:
· Copadichromis atripinnis
· Copadichromis azureus
· Copadichromis chizumuluensis
· Copadichromis cyanocephalus
· Copadichromis diplostigma
· Copadichromis insularis
· Copadichromis mbenjii
· Copadichromis melas
· Copadichromis parvus
· Copadichromis pleurostigma
· Copadichromis trewavasae
· Copadichromis verduyni
Specie descritte appartenenti al gruppo C.virginalis:
· Copadichromis ilesi
· Copadichromis mloto
· Copadichromis virginalis
Come si potrà osservare nei suddetti gruppi non compare il Copadichromis likomae. Questa specie non è inquadrabile perfettamente in nessuno dei suddetti gruppi, perchè morfologicamente sembra un membro del gruppo C.quadrimaculatus o del gruppo C.mbenjii ma differisce da questi per la struttura del nido utilizzato per la riproduzione. Infatti, come nel genere Mchenga, questo nido è costruito sulla sabbia e non vi sono sassi che lo compongono. Per il momento comunque, grazie alla presenza di larghi denti monocuspidi nei maschi adulti, alle 24-28 branchiospine sul primo ceratobranchiale e alle macchie sopra-pettorale e caudale che lo fanno assomigliare, morfologicamente , al gruppo C.quadrimaculatus, il C.likomae rimane inserito nel genere Copadichromis, almeno fino a quando le interrelazioni tra le varie specie e i vari gruppi che compongono questo genere, non siano maggiormente chiarite.
Trewavasae ed Eccles nel 1989, in Malawian cichlid fishes. The classification of some Haplochromine genera, hanno posto le basi dell’attuale classificazione dei ciclidi del Malawi che è largamente basata sui vari tipi di pigmentazione di base, detta anche pattern. Questi sono senz’altro tra i caratteri più importanti per indicare i rapporti di parentela tra i vari generi.
Nello stesso lavoro, descrivevano quindi il nuovo genere Copadichromis (specie tipo Haplochromis quadrimaculatus) il cui nome deriva dal greco kopadi che significa "branco", ovviamente di pesci, e dal suffisso chromis che sta ad indicare pesce. Il nome deriva quindi dall'osservazione di questo genere che normalmente viene visto in branchi. Trewavasae ed Eccles, nella suddetta opera, li descrivevano come ciclidi che si nutrono di plankton di taglia medio piccola. Gli ambienti frequentati dalle specie apparteneti al genere sono quelli rocciosi, di transizione e di acqua aperta. Sono caratterizzati dall’avere una bocca piccola, con deboli mandibole, con piccoli denti ricurvi monocuspidi che nelle femmine e nei piccoli possono essere bicuspidi, sono caratterizzati da un pedicello premascellare allungato, che può essere esteroflesso in avanti formando una bocca protrattile. Piccoli e fitti denti sulla mascella faringeale inferiore, ed un elevato numero, dalle 12 alle 28, di branchiospine sul primo ceratobranchiale. Il genere inizialmente conteneva 17 specie includendo oltre alle sette specie originariamente descritte da Trewavas nel 1935: H. pleurostigma, H.eucinostomus, H.inornatus, H.cyaneus, H.prostoma, H.chrysonotus, H.quadrimaculatus anche altre 10 specie descritte da Iles nel 1960: H.flavimanus, H.mloto, H.virginalis, H.boadzulu, H trimaculatus, H.nkatae, H.jacksoni, H.borleyi, H.pleurostigmoides, H.likomae.
Successivamente Konings tra il 1990 ed il 1999 descriveva C.azureus, C.mbenjii, C.verdujni, C.trewavasae, C.ilesi, e C.geertsi e Stauffer, insieme ad altri, nel 1993 ed insieme a Sato nel 2002, descrivevano: C.conophorus, C.cyclicos, C.thinos e C.atripinnis.
Il lavoro fatto da Stauffer e altri studiosi nel 1993 fu molto importante perchè dimostrarono come la forma e la costruzione del nido siano una manifestazione dei tratti comportamentali ed usarono la forma del nido per delimitare raggruppamenti tassonomici tra le varie specie del Lago Malawi. Basandosi su differenze comportamentali e morfologiche, divisero il genere Copadichromis, in cinque gruppi distinti.
Successivamente, nel 2006, Stauffer e Konings pubblicarono uno studio in cui venivano descritte sei nuove specie: C.melas (ex Copadichromis sp. “midnight mloto”), C.chizumuluensis (ex Copadichormis sp.”chizumulu blu”) , C.diplostigma (ex Copadichrmis sp.”likoma blu”), C.insularis (una parte di C.azureus), C.cyanocephalus (ex Copadichromis sp.”verdujni bluface”) e C.parvus (ex Copadichromis sp.”verdujni dwarf”) e spostarono due dei gruppi descritti dallo stesso Stauffer nel 1993.
Il primo gruppo, caratterizzato da una banda laterale mediana ed un corto pedicello caudale a cui appartenevano C.prostoma e C.boadzulu vennero inclusi nel genere Nyassachromis.
Il secondo gruppo, che si differenziava in modo significativo sia da un punto di vista morfologico che “comportamentale”, diede vita al genere Mchenga. Infatti da un punto di vista morfologico ci sono differenze sia nel pattern melaninico di base, sia nel numero relativamente basso di branchispine sul primo ceratobranchiale e sia nei denti bicuspidi della fila esterna della mascella orale nei maschi, che, nel genere Copadichromis, presentano invece almeno alcuni denti monocuspidi. Dal punto di vista “comportamentale” vi sono grosse differenze di habitat e di costruzione dei nidi che non includono, in queste specie, alcuna roccia o pietra e che vengono quasi sempre, costruiti sulla sabbia.
Dopo questo nuova revisione le specie che rimangono nel genere Copadichromis sono identificate come appartenenti a tre gruppi.
Il gruppo C.quadrimaculatus, il gruppo C.mbenjii ed il gruppo C.virginalis.
Come tutte le specie animali, anche i maschi dei Copadichromis si devono scontrare con due obiettivi contrastanti che riguardano la loro strategia riproduttiva: farsi notare dalle femmine dimostrando il loro vigore e la loro disponibilità alla riproduzione e trovare un posto sicuro e protetto dove riprodursi, per questo motivo l'ambiente in cui si riproducono influenza notevolmente la loro strategia riproduttiva.
Per esempio le specie di Copadichromis che si riproducono in zone rocciose, usano, come zona di riproduzione, quelle meno desiderabili dai potenziali predatori e ladri di uova presenti in questo habitat. Tendono, infatti, ad usare la superficie esposta dei grandi massi che, non offrendo protezione agli mbuna che sono i principali abitanti di questo ambiente, vengono da questi ultimi trascurate.
Quindi, le specie di Copadichromis che si riproducono in habitat roccioso lo fanno lungo una parete verticale di un masso o sotto una sporgenza sovrastante dove l’ombra permette una protezione maggiore dai predatori. Ovviamente, la riproduzione sui massi in habitat roccioso comporta per i maschi territoriali, un grande sforzo energetico per mantenere libero il nido da potenziali predatori e rivali e in considerazione di questo si pensa che i Copadichromis che usano come luogo di riproduzione i grandi massi in habitat puramente roccioso presentano un tratto comportamentale più ancestrale, ossia meno evoluto, tra i Copadichromis, visto che è sicuramente la strategia più dispendiosa.
Tra le strategie per affrontare in modo diverso l'ostile ambiente roccioso abbiamo specie che hanno imparato a riprodursi soltanto durante un particolare periodo dell’anno nel quale quasi tutti i membri adulti di una popolazione si riuniscono in branco. Quest’ultimo comportamento che è stato studiato solo in C.quadrimaculatus (Fryer & Iles, 1972), è in realtà presente anche in altre specie come C.ilesi e C.virginalis, entrambi appartenenti al gruppo C.virginalis. E' facile intuire che la presenza contemporanea nella zona rocciosa, di un enorme numero di utaka che si riproducono, diminuisce la probabilità di predazione delle uova.
Ma il riunirsi in grupppo non è l'unica strategia che le specie di Copadichromis usano per proteggere le proprie riproduzioni. Infatti abbiamo specie che hanno deciso di abbandonare in parte l'habitat roccioso per trasferirsi nella zona di transizione e costruire nidi nella sabbia a ridosso di una roccia o parete rocciosa. Questo modo di riprodursi presenta il vantaggio che il nido è più riparato, cosa che non può essere offerta dall’ambiente roccioso e specie che si riproducono in acqua libera.
Questi comportamenti dimostra un carattere comportamentale dedotto, perchè migliorativo rispetto a quello ancestrale.
Specie descritte appartenenti al gruppo C.quadrimaculatus:
· Copadichromis borleyi
· Copadichromis chrysonotus
· Copadichromis cyaneus
· Copadichromis geertsi
· Copadichromis jacksoni
· Copadichromis nkatae
· Copadichromis pleurostigmoides
· Copadichromis quadrimaculatus
· Copadichromis trimaculatus
Specie descritte appartenenti al gruppo C.mbenjii:
· Copadichromis atripinnis
· Copadichromis azureus
· Copadichromis chizumuluensis
· Copadichromis cyanocephalus
· Copadichromis diplostigma
· Copadichromis insularis
· Copadichromis mbenjii
· Copadichromis melas
· Copadichromis parvus
· Copadichromis pleurostigma
· Copadichromis trewavasae
· Copadichromis verduyni
Specie descritte appartenenti al gruppo C.virginalis:
· Copadichromis ilesi
· Copadichromis mloto
· Copadichromis virginalis
Come si potrà osservare nei suddetti gruppi non compare il Copadichromis likomae. Questa specie non è inquadrabile perfettamente in nessuno dei suddetti gruppi, perchè morfologicamente sembra un membro del gruppo C.quadrimaculatus o del gruppo C.mbenjii ma differisce da questi per la struttura del nido utilizzato per la riproduzione. Infatti, come nel genere Mchenga, questo nido è costruito sulla sabbia e non vi sono sassi che lo compongono. Per il momento comunque, grazie alla presenza di larghi denti monocuspidi nei maschi adulti, alle 24-28 branchiospine sul primo ceratobranchiale e alle macchie sopra-pettorale e caudale che lo fanno assomigliare, morfologicamente , al gruppo C.quadrimaculatus, il C.likomae rimane inserito nel genere Copadichromis, almeno fino a quando le interrelazioni tra le varie specie e i vari gruppi che compongono questo genere, non siano maggiormente chiarite.
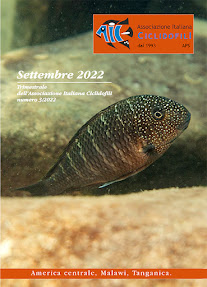
Commenti
Posta un commento