Tassonomia, classificazione e nomenclatura
Ripropongo questo articolo scritto da Ivan Salvadori
L'uomo ha per sua natura la necessità di classificare tutto ciò che è intorno a se. Questo in tutti i campi. Dalla musica all'arte dalle cose ai sentimenti. Questo per due motivi principali. Avere tutto sotto controllo e la speranza e la necessità di averli capiti.
Classificare la natura è stata ed è ancora una delle cose più difficili, se non impossibili, che ha provato a fare l'uomo in questo senso.
La persona che ha posto le basi al modo in cui ancora oggi si cerca di farlo è Karl von Linne, meglio noto come Linneo con la pubblicazione del Systema Naturae. (1735)
Quello che ad oggi ci sembra una cosa così ovvia in realtà non lo è stata per molto tempo.
Aristotele per esempio aveva proposto una classificazione del regno animale secondo il modo di locomozione. Questo sistema che oggi ci sembra molto lontano è in realtà durato circa duemila anni grazie soprattutto al fatto che l'aristotelismo fu assunto come scienza dalla Chiesa Cattolica.
Con Linneo assistiamo a un posizionamento di ogni organismo, mediante una scala gerarchica, in una serie di gruppi tassonomici, detti taxa.
Le principali suddivisioni dal più generico al più specifico sono:
E' interessante notare che il 1 gennaio 1758, giorno della pubblicazione della decima edizione del Systema Naturae è considerato dal Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) il punto di partenza della nomenclatura zoologica moderna.
Linneo è il primo che a usato per catalogare la natura, una nomenclatura binominale, in pratica classificando una specie con un binomio latino: il nome del genere, comune ad una serie di specie, e il nome specifico che caratterizza e distingue le varie specie di quel genere. Il nome formato da queste due parti è conosciuto come nome scientifico di una specie. Quando una specie risulta ulteriormente suddivisa, ad esempio in più sottospecie o varietà, abbiamo la cosiddetta nomenclatura trinominale.
Ma cerchiamo di capire a che punto siamo nella scala gerarchica riferendoci ai ciclidi
Regno: animalia
phylum: Cordata
classe: actinopteryigii
ordine: perciformi
famiglia: Cichlidae
genere
specie
Ecco quando parliamo di ciclidi parliamo di famiglia.
All'interno poi della famiglia ciclidi ci sono varie sottofamiglie. Queste sono allo stato attuale: Astronotinae, Cichlasomatinae, Cichlinae, Etroplinae, Geophaginae, Heterochromidinae, Pseudocrenilabrinae, Ptychochrominae, Retroculinae, Cichlidae in incertae sedis.
Tutti i ciclidi del Malawi appartengono alla sottofamiglia Pseudocrenilabrinae.
L'importanza di dare nel nostro caso ad un pesce un nome esatto è quella di permettere a tutti di capire di che pesce si tratta. Se ci pensate anche se andate nella vicina Francia o nella lontana Australia, se parlate di Labeotropheus trewavasae tutti sanno di che pesce parlate.
Naturalmente non proprio tutti. Vi capiranno quelli che conoscono il nome scientifico della determinata specie o almeno genere. E' proprio questa l'importanza fondamentale di chiamare una specie con il proprio nome scientifico.
Arriviamo quindi a come scrivere in modo corretto un nome scientifico.
Il nome scientifico di una specie si deve scrivere con la prima lettera del genere in maiuscolo e il nome della specie in minuscolo. Inoltre, ma spesso questo non accade, dovrebbe essere scritto in corsivo.
MODO CORRETTO
Copadichromis atripinnis
MODI SCORRETTI
copadicromis atripinnis
COPADICHROMIS atripinnis
Copadichromis Atripinnis.
Abbastanza semplice direi, almeno per le specie descritte scientificamente.
Ci sono però molti ciclidi non ancora descritti e ancora di più sono quelli che sono considerate varietà di una specie valida.
Come scrivere un ciclide di questo tipo in modo corretto?
Ci vengono in aiuto principalmente due parole che troviamo spesso dopo il genere.
La prima la più usata è subspecies, abbreviata in sp.
L'uso di questa abbreviazione ha il significato che la specie non è stata ancora descritta scientificamente ma alla quale diamo per il momento un nome ufficioso. Questo nome va messo tra virgolette e deve iniziare con la lettera maiuscola solo se indica una località. l' abbreviazione sp. così come il nome che viene dopo non va in corsivo.
Quindi risulta corretto il nome Aulonocara sp.'stuartrandi Maleri' e non altri modi.
La seconda parola che ci viene in aiuto è confer, abbreviato in cf. Confer significa confronta e vuol dire che si pensa che una popolazione appartiene ad una determinata specie ma non si hanno abbastanza elementi per confermarlo.
Un esempio lo abbiamo con Lethrinops cf.longipinnis 'Ntekete'. Come si vede subito, in questo caso genere e specie vanno scritte in corsivo tutto il resto no.
Per quelle che vengono invece considerate varietà geografiche di una determinata specie, il nome della località va scritta, sempre tra virgolette in ultimo.
Quindi risulta corretto per esempio Labidochromis caeruleus 'Lions Cove' così come Aulonocara sp.'stuargranti Maleri' 'Chipoka' od ancora il già citato Lethrinops cf.longipinnis 'Ntekete'
Ci sono poi alcuni casi nei quali abbiamo due specie descritte, in modo separato, da studiosi diversi, che però, non hanno abbastanza differenze, per essere due specie diverse. Questo vuol dire, in realtà che questi studiosi hanno descritto la stessa specie chiamandola in modi diversi. Il nome esatto della specie sarà in questo caso quello che le aveva dato chi ha pubblicato il suo lavoro per primo, quindi la più vecchia. La nuova descrizione viene considerata un sinonimo della prima e a livello scientifico non ha valore.
Un esempio lo abbiamo con Aulonocara stuargranti e Aulonocara steveni.
La seconda, è stata descritta alcuni anni dopo l'Aulonocara stuargranti ma non essendoci abbastanza differenze o luoghi di convivenza tra queste due “specie”, A.steveni viene considerata sinonimo di A.stuargranti che rimane il nome valido della specie
Questo discorso accade anche a livello di generi. Ad esempio Eccles e Trewavasae descrissero nel 1989 il genere Maravichromis come genere diverso da Mylochromis già descritto nel 1920 da Regan e vi inserirono come specie tipo Maravichromis ericotaenia. A suo tempo, nel 1922, quando Regan descrisse Haplochromis ericotaenia non lo inserì nel genere Mylochormis perchè in qualche modo secondo lui non rientrante.
Con il tempo si è visto però che Il genere Maravichromis poteva essere considerato un sinonimo di Mylochromis e quindi tutti i pesci descritti o in qualche modo rientranti nel genere entrarono a far parte del genere Mylochromis compreso il Mylochromis ericotaenia.
L'uomo ha per sua natura la necessità di classificare tutto ciò che è intorno a se. Questo in tutti i campi. Dalla musica all'arte dalle cose ai sentimenti. Questo per due motivi principali. Avere tutto sotto controllo e la speranza e la necessità di averli capiti.
Classificare la natura è stata ed è ancora una delle cose più difficili, se non impossibili, che ha provato a fare l'uomo in questo senso.
La persona che ha posto le basi al modo in cui ancora oggi si cerca di farlo è Karl von Linne, meglio noto come Linneo con la pubblicazione del Systema Naturae. (1735)
Quello che ad oggi ci sembra una cosa così ovvia in realtà non lo è stata per molto tempo.
Aristotele per esempio aveva proposto una classificazione del regno animale secondo il modo di locomozione. Questo sistema che oggi ci sembra molto lontano è in realtà durato circa duemila anni grazie soprattutto al fatto che l'aristotelismo fu assunto come scienza dalla Chiesa Cattolica.
Con Linneo assistiamo a un posizionamento di ogni organismo, mediante una scala gerarchica, in una serie di gruppi tassonomici, detti taxa.
Le principali suddivisioni dal più generico al più specifico sono:
E' interessante notare che il 1 gennaio 1758, giorno della pubblicazione della decima edizione del Systema Naturae è considerato dal Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) il punto di partenza della nomenclatura zoologica moderna.
Linneo è il primo che a usato per catalogare la natura, una nomenclatura binominale, in pratica classificando una specie con un binomio latino: il nome del genere, comune ad una serie di specie, e il nome specifico che caratterizza e distingue le varie specie di quel genere. Il nome formato da queste due parti è conosciuto come nome scientifico di una specie. Quando una specie risulta ulteriormente suddivisa, ad esempio in più sottospecie o varietà, abbiamo la cosiddetta nomenclatura trinominale.
Ma cerchiamo di capire a che punto siamo nella scala gerarchica riferendoci ai ciclidi
Regno: animalia
phylum: Cordata
classe: actinopteryigii
ordine: perciformi
famiglia: Cichlidae
genere
specie
Ecco quando parliamo di ciclidi parliamo di famiglia.
All'interno poi della famiglia ciclidi ci sono varie sottofamiglie. Queste sono allo stato attuale: Astronotinae, Cichlasomatinae, Cichlinae, Etroplinae, Geophaginae, Heterochromidinae, Pseudocrenilabrinae, Ptychochrominae, Retroculinae, Cichlidae in incertae sedis.
Tutti i ciclidi del Malawi appartengono alla sottofamiglia Pseudocrenilabrinae.
L'importanza di dare nel nostro caso ad un pesce un nome esatto è quella di permettere a tutti di capire di che pesce si tratta. Se ci pensate anche se andate nella vicina Francia o nella lontana Australia, se parlate di Labeotropheus trewavasae tutti sanno di che pesce parlate.
Naturalmente non proprio tutti. Vi capiranno quelli che conoscono il nome scientifico della determinata specie o almeno genere. E' proprio questa l'importanza fondamentale di chiamare una specie con il proprio nome scientifico.
Arriviamo quindi a come scrivere in modo corretto un nome scientifico.
Il nome scientifico di una specie si deve scrivere con la prima lettera del genere in maiuscolo e il nome della specie in minuscolo. Inoltre, ma spesso questo non accade, dovrebbe essere scritto in corsivo.
MODO CORRETTO
Copadichromis atripinnis
MODI SCORRETTI
copadicromis atripinnis
COPADICHROMIS atripinnis
Copadichromis Atripinnis.
Abbastanza semplice direi, almeno per le specie descritte scientificamente.
Ci sono però molti ciclidi non ancora descritti e ancora di più sono quelli che sono considerate varietà di una specie valida.
Come scrivere un ciclide di questo tipo in modo corretto?
Ci vengono in aiuto principalmente due parole che troviamo spesso dopo il genere.
La prima la più usata è subspecies, abbreviata in sp.
L'uso di questa abbreviazione ha il significato che la specie non è stata ancora descritta scientificamente ma alla quale diamo per il momento un nome ufficioso. Questo nome va messo tra virgolette e deve iniziare con la lettera maiuscola solo se indica una località. l' abbreviazione sp. così come il nome che viene dopo non va in corsivo.
Quindi risulta corretto il nome Aulonocara sp.'stuartrandi Maleri' e non altri modi.
La seconda parola che ci viene in aiuto è confer, abbreviato in cf. Confer significa confronta e vuol dire che si pensa che una popolazione appartiene ad una determinata specie ma non si hanno abbastanza elementi per confermarlo.
Un esempio lo abbiamo con Lethrinops cf.longipinnis 'Ntekete'. Come si vede subito, in questo caso genere e specie vanno scritte in corsivo tutto il resto no.
Per quelle che vengono invece considerate varietà geografiche di una determinata specie, il nome della località va scritta, sempre tra virgolette in ultimo.
Quindi risulta corretto per esempio Labidochromis caeruleus 'Lions Cove' così come Aulonocara sp.'stuargranti Maleri' 'Chipoka' od ancora il già citato Lethrinops cf.longipinnis 'Ntekete'
Ci sono poi alcuni casi nei quali abbiamo due specie descritte, in modo separato, da studiosi diversi, che però, non hanno abbastanza differenze, per essere due specie diverse. Questo vuol dire, in realtà che questi studiosi hanno descritto la stessa specie chiamandola in modi diversi. Il nome esatto della specie sarà in questo caso quello che le aveva dato chi ha pubblicato il suo lavoro per primo, quindi la più vecchia. La nuova descrizione viene considerata un sinonimo della prima e a livello scientifico non ha valore.
Un esempio lo abbiamo con Aulonocara stuargranti e Aulonocara steveni.
La seconda, è stata descritta alcuni anni dopo l'Aulonocara stuargranti ma non essendoci abbastanza differenze o luoghi di convivenza tra queste due “specie”, A.steveni viene considerata sinonimo di A.stuargranti che rimane il nome valido della specie
Questo discorso accade anche a livello di generi. Ad esempio Eccles e Trewavasae descrissero nel 1989 il genere Maravichromis come genere diverso da Mylochromis già descritto nel 1920 da Regan e vi inserirono come specie tipo Maravichromis ericotaenia. A suo tempo, nel 1922, quando Regan descrisse Haplochromis ericotaenia non lo inserì nel genere Mylochormis perchè in qualche modo secondo lui non rientrante.
Con il tempo si è visto però che Il genere Maravichromis poteva essere considerato un sinonimo di Mylochromis e quindi tutti i pesci descritti o in qualche modo rientranti nel genere entrarono a far parte del genere Mylochromis compreso il Mylochromis ericotaenia.
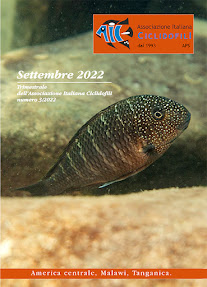
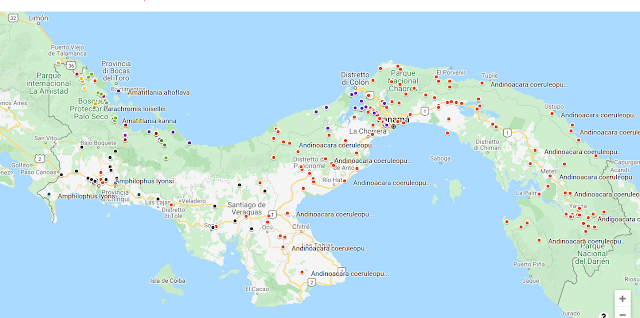
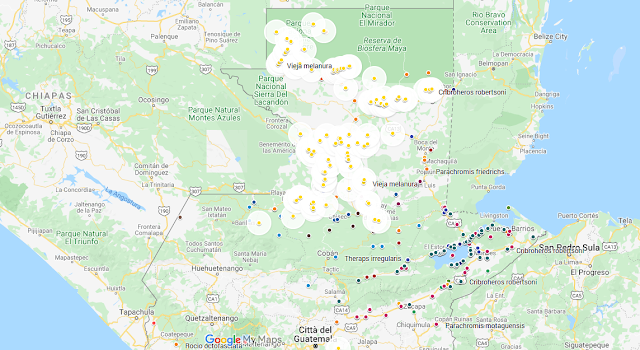
Commenti
Posta un commento